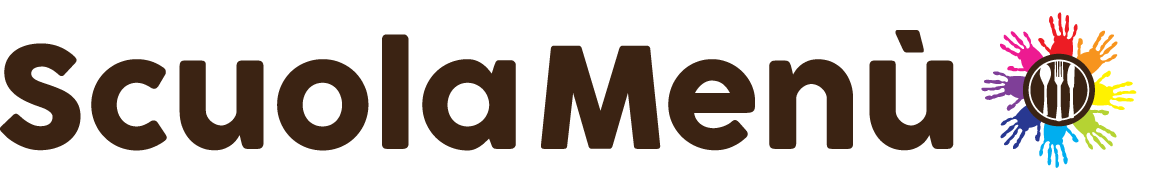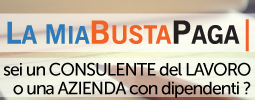“Nel bambino piccolo la fame dell’amore e della presenza materna non è meno grande della fame di cibo" [Bowlby, 1988]
La teoria dell’attaccamento, proposta dallo psicologo John Bowlby a partire dagli anni '50, sostiene che ogni essere umano manifesta un'innata predisposizione a sviluppare relazioni di attaccamento con le proprie figure genitoriali (o caregiver). Tali relazioni si manifestano a partire dai 6 mesi fino ai 2 anni e il loro scopo è quello di garantire la sicurezza e la protezione nei confronti dei pericoli ai quali il bambino può andare incontro.
La teoria dell'attaccamento è il risultato di diversi approcci teorici derivanti da differenti aree di studio, tra cui l'etologia (si ricordano gli studi sull'imprinting di Konrad Lorenz sulle oche selvatiche), la teoria evoluzionistica e la teoria dei sistemi.
Non tutti i rapporti umani, pur essendo significativi, devono essere considerati relazioni di attaccamento; affinché si possa parlare di una relazione di attaccamento, devono essere presenti almeno tre condizioni di base:
1. La ricerca della vicinanza tra la persona che ricerca l'attaccamento e quella che lo offre.
2. La presenza di reazioni di protesta di fronte alla separazione (manifestazioni che hanno come scopo quello di richiamare la figura di attaccamento quando si allontana o non è disponibile).
3. Lo sviluppo di una "base sicura" (particolare atmosfera di sicurezza e di fiducia che si instaura tra il soggetto e la figura di attaccamento)
Il concetto di "base sicura" è stato introdotto da un' altra psicologa, Mary Ainsworth, ed è stato successivamente valorizzato da Bowlby stesso, che ha spiegato come un bambino, per esplorare in modo sereno l’ambiente esterno, abbia bisogno di sentirsi sicuro di poter ritornare in qualsiasi momento ne senta il bisogno.
A partire dai 24 mesi di età, il bambino sviluppa delle rappresentazioni mentali relative alla relazione instaurata con i genitori: i Modelli Operativi Interni (MOI). Quest'ultimi indicano rappresentazioni di se stessi e delle persone con le quali si è stabilito un legame significativo: rappresentano modelli di sé con l’altro, vale a dire dunque della relazione. I MOI sono strutture mentali affettivo-cognitive che vengono utilizzate per rapportarsi con l'esterno. Sono credenze ed aspettative individuali, sviluppate sulla base dell’interiorizzazione della qualità delle interazioni con il caregiver: in base al tipo di relazione primaria, il soggetto crea una rappresentazione mentale del Sè e dell' altro, orientando in base a questi elementi le sue future relazioni di attaccamento nell'ambito di contesti affettivamente significativi.
Bowlby sostiene che la funzione svolta dall'attaccamento continua ad essere importante per tutta l'esistenza di un individuo: la rappresentazione mentale della relazione durante l'infanzia con i genitori si rifletterà, in maniera inconscia, sulle future relazioni del soggetto divenuto ormai adulto. Sebbene i MOI siano strutture mentali che tendono ad avere una certa stabilità nel tempo, questa non implica necessariamente che questi non si possano modificare nel corso della vita.
Un altro aspetto importante, emerso durante studi condotti intorno al 1945 da uno psicoanalista austriaco (Renè Spitz) all'interno di brefotrofi, è il fatto che la mancanza di cure materne ha un peso molto negativo sullo sviluppo dell'emotività, della psicomotricità, del linguaggio e del comportamento sociale del bambino. E' partendo dallo stesso tipo di studi che Bowlby constata che i bambini hanno bisogno della vicinanza fisica e psicologica di una mamma, di una figura verso la quale sviluppare una particolare forma di attaccamento, relazione che non interessa solo la nutrizione, ma il complesso delle cure che la figura adulta ha nei confronti del piccolo.
Bowlby ritiene che sia i neonati che i caregivers siano biologicamente predisposti a sviluppare comportamenti di attaccamento.
Da questo punto di vista l'attaccamento è un sistema importante tanto quello che regola l'assunzione del cibo: esso orienta il bambino verso le figure di protezione, ovvero le figure di attaccamento, e ricerca in queste figure il rifugio, la base sicura, in caso di pericolo.
Di seguito viene riportata la classificazione dei tipi di attaccamento proposta dalla psicologa sopracitata Ainsworth:
1) Stile sicuro: il bambino vede nel genitore la base sicura dalla quale si può allontanare per esplorare il mondo e alla quale può ritornare nel momento del bisogno o se ne sente la necessità. Il caregiver è sensibile alle richieste del bambino, disponibile e pronto a dargli protezione nel momento in cui il bambino lo richiede. Le relazioni interpersonali future in generale saranno improntate sul rispetto di sé e dell’altro.
2) Stile insicuro/evitante: il bambino percepisce il caregiver come qualcuno a cui non chiedere aiuto nel momento del bisogno, poiché tale figura si dimostra inaffidabile, poco presente e spesso rifiutante. Il bambino si mostra insicuro e prova sfiducia verso il mondo esterno e possiede la convinzione di non essere amato. Le relazioni interpersonali future saranno caratterizzate da freddezza emotiva.
3) Stile ansioso/ambivalente: il bambino percepisce il genitore come disponibile in maniera discontinua: a volte la madre è presente, ma spesso è assente. Perciò in questi bambini è presente l’ "ansia da abbandono" e il bambino si percepirà come persona da amare in maniera discontinua. Nelle relazioni interpersonali il bambino, preso dall' impulso, mostrerà grande gelosia, possessività e ossessione; idealizzerà gli altri e sminuirà il proprio sé, con sentimenti di sfiducia circa le proprie capacità.
4) Stile disorganizzato: il caregiver appare allo stesso tempo come una figura spaventata e spaventante e il bambino può mostrare reazioni completamente opposte nello stesso breve lasso di tempo di fronte a situazioni stressanti. L' immagine di sé e dell’altro è vissuta in maniera negativa, vi è rifiuto dell’intimità e spesso conflitto tra questo e la ricerca dell’altro dal quale tali soggetti a volte si mostrano dipendenti.
Tra questi diversi stili di attaccamento, ovviamente quello che consente l'instaurarsi di un così detto circolo virtuoso, è proprio lo stile di attaccamento sicuro. A partire da questa relazione positiva madre (caregiver)-bambino, in quest'ultimo si sviluppa un senso di sicurezza e di fiducia in sé, che lo porteranno a saper gestire situazioni difficili che si presenteranno con lo sviluppo. Se l'adulto sarà responsivo e competente, il bambino si sentirà parte della famiglia, anche nei momenti più critici del suo ciclo di vita.
Se qualcosa non funziona in questo primo prezioso scambio relazionale, il bambino potrà mettere in atto comportamenti che possono aiutarlo a difendersi, anche se in modo disfunzionale per la sua crescita e il suo benessere futuro. L'indisponibilità dell'adulto di riferimento, da cui il bambino dipende per la sua protezione e sopravvivenza, creerà nel bambino una vulnerabilità verso la paura della perdita dell'altro.
L'immagine di sé che sviluppa un individuo che ha avuto un attaccamento sicuro è di essere una persona amabile, degna di essere amata, con buona autostima, che ha fiducia negli altri (ma non in modo indiscriminato). Sarà un individuo amabile con le persone amichevoli, difeso con chi percepisce come ostile, si prenderà cura di sé e delle persone che ama, non si affiderà alle persone che non conosce, sarà selettivo nei comportamenti empatici e nel rivelare se stesso, saprà appoggiarsi agli altri.
L'essere autonomo nella relazione e il divenire in grado di allontanarsi dalla famiglia sono strettamente connessi al senso di fiducia in sé, e ciò è più facile se si ha avuto una madre responsiva e non invasiva o invischiante. Da una buona esperienza di appartenenza si sviluppa una funzionale capacità di autonomia.
Silvia Giorgetti: laureanda in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia presso l'Università degli Studi di Firenze;
Susanna Renga: laureanda in Psicologia Scolastica e di Comunità presso l'Università di Bologna;